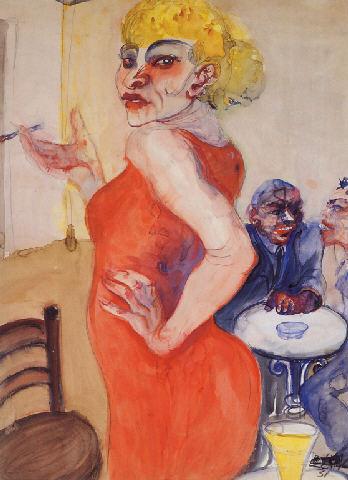L'inferno di
Elfriede Lohse-Wächtler
(dall'antologia AA. VV., "Il male al cinema- Moovies Shadows and Lights", edizioni Lulu, Mostra
d'Arte Cinematografica di Venezia 2015)

clic sulla copertina per
ingrandire
Malgrado tutto quello attraverso cui sono passata sono abbastanza
stupida
da credere che la gente buona esista ancora.
Elfriede Lohse- Wächtler
Elfriede Lohse-Wächtler, Lissy (1931)
Travagliata fu l'esistenza della pittrice di avanguardia Elfriede
Lohse-Wächtler, la cui vicenda personale, con la diagnosi di
“schizofrenia”, il ricovero, l'interdizione, la sterilizzazione forzata,
la morte, s’intersecò con la grande tragedia collettiva degli anni del
nazismo, passato di orrore e sacrificio che nessuna coscienza umana
dovrà mai dimenticare, evento drammatico in cui il Male prevalse in una
forma crudele e insensata: un’aberrante ideologia politica che spinse
uomini a costringere altri fratelli a perdere i lineamenti stessi
dell’umanità abbrutiti dall’odio e dalla persecuzione.
Elfriede nacque il 4 dicembre 1899 a Loebtau come Anna Frieda Wächtler
(fu lei, poi, a ribattezzarsi “Elfriede”), in una famiglia borghese. Suo
padre, Gustav Adolf, coltivava grandi speranze per la figlia, perciò
disapprovò la sua scelta “eccentrica” d’intraprendere la carriera
artistica.
Nonostante la sua opposizione, volitiva, intraprendente, desiderosa sin
da bambina di esprimersi creativamente, per studiare disegno nel 1915
Elfriede s’iscrisse all'Accademia d’Arte di Dresda (città, che insieme a
Monaco di Baviera e Hannover era, allora, in Germania fervido centro che
consentiva scambi e sviluppi creativi fra “Espressionismo” e “Dadaismo”
apportando notevoli contributi tedeschi alla rivoluzione artistica del
Novecento), ma poi cambiò corso di studi per impegnarsi nella grafica
applicata, in particolare nel batik
(termine derivante dalle parole indonesiane amba,
“scrivere”, e titik,
“punto, goccia”, col significato di ciò
che si disegna),
la
tecnica usata per colorare i tessuti
coprendo le zone che non si vogliono tinte.
In spirito d’indipendenza lasciò la casa paterna, tagliò corti i
capelli, indossò abiti maschili, iniziò a fumare la pipa in pubblico e
cominciò a tingere tessuti e a realizzare cartoline d’auguri litografate
per guadagnarsi da vivere e finanziarsi gli studi, che continuò sotto la
guida del professore d’arte, pittore, grafico e incisore, Oskar Georg
Erler.
Adottato lo pseudonimo maschile di Nikolaus Wächtler, Elfriede
frequentò le avanguardie artistiche del tempo, ebbe come amici il
pittore e incisore espressionista Conrad Felixmüller, membro del partito
comunista tedesco, e Otto Dix,
pure pittore e incisore, noto per le sue raffigurazioni spietate e
duramente realistiche della Repubblica di Weimar1
e della brutalità della guerra. Inoltre
aderì al “Dadaismo”, movimento nato
a Zurigo, nella Svizzera neutrale
della Prima guerra mondiale, e sviluppatosi tra il 1916 e
il 1920, che interessò
soprattutto l’arte, la letteratura e il teatro, i cui gli artisti
manifestavano la loro politica anti bellica con il rifiuto degli
standard artistici, attraverso opere che erano contro le convenzioni
dell'epoca, contro le ideologie politiche, contro la ragione e la
logica, contro l'arte stessa, proponendosi volutamente irrispettosi e
stravaganti, ricercando la totale libertà creativa, per la quale
utilizzavano tutti i materiali e le forme disponibili.
Fu in quegli anni che Elfriede maturò anche una coscienza politica e
sociale.
Sorprendendo tutti, nel 1921 sposò Kurt Lohse, un allievo d’arte
squattrinato, pittore e cantante lirico, che conduceva una vita
sregolata e che, mentre era sposato con lei, ebbe tre figli da un’altra
donna, motivi, questi, che la spinsero negli anni successivi a ripetute
separazioni.
Nel 1926 aderì all'Unione di Donne Artiste e Amici dell'Arte di Amburgo,
e nel 1928 partecipò a numerose mostre del movimento artistico
d’avanguardia
Neue Sachlichkeit
(“Nuova Oggettività”)
nato in Germania dopo la prima guerra mondiale,
riguardante soprattutto la pittura, che proponeva un rinnovato interesse
per la realtà, caratterizzato da un immaginario poco accomodante e
spesso grottesco, distorto, sconfinante nell’astratto pur mantenendosi
nel figurativismo, derivante dal dolore fisico o mentale di artisti che
avevano vissuto gli orrori della guerra, trascorrendo lunghi periodi in
ospedale e portando con sé nel dopoguerra le cicatrici dell’esperienza
vissuta. Di fronte al materialismo disinvolto della Repubblica di Weimar
e alla crescente minaccia del nazismo gli esponenti della “Nuova
oggettività” nelle loro tele mettevano in
ridicolo la corruzione della società contemporanea e lo spettro del
militarismo che aleggiava minaccioso sulla Germania degli anni ’20,
elaborando ritratti caratterizzati da volti con lineamenti
innaturalmente deformati e corpi contorti. Condannato dal nazismo come
arte degenerata, nel 1933 gli esponenti del movimento furono costretti a
rifugiarsi all’estero. Anni dopo una versione meno esasperata di questo
stile avrebbe, poi, svolto un ruolo importante nella nascita dell’
“Espressionismo astratto”, che si esaurì con la fine della Repubblica
di Weimar e con la presa del
potere da parte dei nazisti,
che consideravano questa corrente entartete Kunst,
“arte degenerata”,
espressione che, nella Germania del regime
nazista, indicava quelle
forme d'arte che riflettevano
valori o estetiche contrari
alle concezioni naziste, e non esaltavano o, addirittura, si opponevano,
ai valori ritenuti tipici della razza
ariana e delle sue tradizioni
culturali.
Allontanatasi da Kurt nel 1926, nonostante i successi iniziali Elfriede
cominciò a trovarsi in difficoltà economiche, tanto che poteva contare
sul sostegno sociale.
Lontana dagli amici che aveva in comune con Kurt, oppressa dalle
preoccupazioni economiche, la sua salute mentale cominciò a vacillare e
si palesarono i primi segni dei deliri paranoici che aumentarono finché,
nel 1929 ebbe un crollo psichico mentre si trovava ad Amburgo, dove
viveva, e fu ricoverata nell’ospedale psichiatrico di
Klein-Friedrichsberg.
Durante il ricovero, durato due mesi, dopo un iniziale periodo di apatia
Elfriede sviluppò un forte impulso creativo e riprese a disegnare e a
dipingere, creando
una serie di sessanta disegni,
schizzi a matita
e pastelli,
in cui rappresentava se stessa, la vita quotidiana nell’ospedale, il
giardino dell’ospedale, un paesaggio invernale,
i pazienti, soprattutto
sorprendenti ritratti di donne ricoverate, le “Teste di Friedrichsberg”,
entusiasmando i critici che, per la rappresentazione cruda, grottesca,
"brutta" (com'era tipico degli espressionisti tedeschi che deformavano
l'oggetto rappresentato) di personaggi colti in miseria e solitudine
morale, la paragonarono a Grosz, Kokoschka e Schiele.
Dopo il suo recupero, e la separazione definitiva da Kurt Lohse,
l'artista visse un periodo molto creativo, il
più felice della sua carriera artistica,
esponendo nel maggio del 1929 i suoi ritratti al “Kunstsalon Marie Kunde”,
a questa mostra seguirono altre esposizioni, e la realizzazione di
numerose opere, di fantasia,
dipinti del porto di Amburgo e degli
ambienti più squallidi della città, ritratti di
lavoratori e di prostitute
dei quartieri a luci rosse di Amburgo,
ed anche molti autoritratti. È
del 1931 il suo lavoro più noto, Lissy, il ritratto a tre quarti
di lunghezza di una prostituta bionda, pesantemente truccata,
caricaturale e quasi grottesca, che, una mano appoggiata su un fianco,
l’altra che stringe una sigaretta, guarda fisso lo spettatore. Secondo
alcuni critici quest’opera sarebbe un autoritratto che indicherebbe
l'identificazione dell'artista con le figure emarginate della malavita
di Amburgo.
Nonostante la partecipazione ad alcune mostre, il ricavato dalle vendite
delle sue opere e piccoli sussidi,
il successo fu di breve durata ed
Elfriede continuò a versare in condizioni di estrema povertà. A metà del
1931, a causa dei problemi economici e del crescente isolamento in cui
viveva, negli
anni in cui la Germania precipitava verso il nazismo, povera, senza
amici, fece ritorno a casa e affondò sempre più nel suo male.
Nel 1932,
su richiesta del padre, sgomento per le condizioni di quella figlia che
sentiva così estranea, con la quale sempre difficili erano stati i
rapporti, e convinto di affidarla a un luogo di giuste cure, Elfriede fu
ricoverata nell'ospedale psichiatrico di Arnsdorf, presso Dresda: qui le
fu diagnosticata la “schizofrenia”.
Ancora ottimista verso il suo futuro, Elfriede continuò a dipingere e a
scrivere ai suoi chiedendo di poter lasciare l’ospedale, ma il suo
destino era segnato, intrecciato al nazismo che, ormai, aveva mostrato
il suo vero volto, rivelando inequivocabilmente agli occhi del mondo la
sua natura violenta e aggressiva, assumendo Hitler tutte le cariche del
potere e trasformando la Germania, nell’arco di pochi mesi, in uno Stato
totalitario, abolendo il regime parlamentare, disciogliendo i sindacati
e le organizzazioni autonome dei lavoratori, dichiarando illegale e
perseguitando a morte l’opposizione, privando le donne del diritto di
voto, sopprimendo tutti i partiti, mettendo sotto ferreo controllo la
radio e il sistema scolastico, promulgando le prime leggi antisemite.
L’antisemitismo era uno dei principi cardine su cui si basava
l’ideologia hitleriana, secondo la quale, come espresso nel Mein
Kampf (“La mia battaglia”) da Adolf Hitler, bisognava salvaguardare
la purezza della razza ariana- assolutamente superiore, destinata da Dio
a dominare il mondo per il bene di tutti i popoli- eliminando qualunque
elemento “impuro”, soprattutto la razza semita, giudicata di natura
inferiore e accusata di voler trascinare il mondo intero verso la più
spaventosa corruzione. Si sviluppò, allora, con tutta la sua atroce
progressiva drammaticità attraverso una serie di leggi che tolsero agli
ebrei tedeschi i diritti civili e che condussero alla deportazione in
Germania di migliaia di uomini e donne (che venivano impegnati nei campi
di lavoro in sostituzione degli operai tedeschi in guerra),
all’eliminazione degli ebrei e degli oppositori al nazismo, alla
creazione di Lager in Polonia, in Germania e in altri Paesi,
campi di concentramento, poi diventati campi di sterminio, come
Auschwitz, Dachau, Mauthausen,
Ravensbrück,2
quest’ultimo esclusivamente femminile, voluto da Hitler per eliminare le
donne “non
conformi”, prigioniere politiche, prostitute, lesbiche, zingare,
disabili, che qui subivano le violenze più atroci che si possano
infliggere ad una donna: sterilizzazioni, aborti forzati e stupri.
In questi
Lager
la ferocia nazista condusse esseri umani incolpevoli all’abiezione,
all’avvilimento, alla prostrazione, nella carne e nello spirito, e
soppresse circa 14 milioni di uomini di cui 6 milioni di ebrei,
scrivendo la pagina più vergognosa della storia dell’umanità.
“La mia scienza pedagogica è dura. Il debole deve essere spazzato via.
Nei centri del mio nuovo Ordine verrà allevata una gioventù che
spaventerà il mondo. Io voglio una gioventù che compia grandi gesta,
dominatrice, ardita, terribile. Gioventù deve essere tutto questo. Essa
deve sopportare il dolore, non deve avere nulla di debole o di
effeminato. L’animale rapace, libero e dominatore, deve brillare anche
dai suoi occhi. Forte e bella voglio la mia gioventù. La farò istruire
in ogni esercizio fisico. Voglio una gioventù atletica. Questa è la
prima cosa e la più importante. Così distruggerò i millenni di
addomesticamento dell’umanità ed avrò di fronte a me il materiale
nobile, puro della natura e potrò creare cose nuove. Non voglio
un’educazione intellettuale. Il sapere mi rovina la gioventù. Al più le
lascio imparare quello per cui si sente portata seguendo il gioco dei
suoi istinti. ”3
Fra le politiche sociali razziste attuate dalla Germania
di Hitler, ossessionato dai canoni di purezza e bellezza derivategli dal
suo “sentirsi” artista, profondamente avverso all’handicap fisico e
mentale, e convinto che lo stato di debolezza della nazione dipendesse
all'esistenza di "elementi degenerati" che avevano compromesso la
purezza della popolazione e che, pertanto, dovevano essere eliminati il
prima possibile, incoraggiando, invece, la riproduzione dei forti e dei
razzialmente puri,
trovò spazio anche
un’altra malvagità, l’eugenetica nazista,
finalizzata al miglioramento della razza mediante la soppressione
delle persone considerate "vite di nessun valore" (Lebenunwertes
Leben in tedesco), dissidenti, omosessuali, deviati, ritardati,
malati di mente, ebrei, zingari, ecc., prima con la sterilizzazione
coatta, per impedire di riprodursi, in modo da non diffondere i propri
geni all'interno della popolazione, e poi con la morte.
Nel 1939 fu, così, avviato
da Hitler e dai suoi fedelissimi, il programma
“Aktion
T4”,
chiamato più semplicemente il "T4", che
mirava all'eliminazione dei bambini affetti da handicap fisici e
mentali, e
all'eutanasia di massa degli adulti disabili, e che s’interruppe,
ma solo formalmente, su pressione dell’opinione pubblica e della Chiesa,
nell’agosto del 1941.
Si calcola che, tra il 1939 e il 1945, furono sterminate dai nazisti
250.000 persone disabili, malati di mente, disabili fisici e quelli
ritenuti “ indegni della vita”.
In questo contesto Elfriede si avviò al drammatico epilogo della sua
esistenza.
Nel 1935, come consentito dalla legge per la prevenzione della prole
geneticamente difettosa contro chi era affetto da “tare ereditarie”,
dopo un suo primo rifiuto,
fu sottoposta a sterilizzazione forzata nella clinica di Dresda,
il cui vicedirettore era un fervente nazista, poi le
fu negata la libertà di lasciare la casa di cura.
Nel 1937 fu etichettata come autrice di arte degenerata e gran parte dei
suoi lavori furono confiscati o distrutti.
Oppressa dall’umiliazione subita della sterilizzazione Elfriede smise di
dipingere, eppure, anche se priva di cure adeguate, malnutrita e
sofferente, ancora sperava in un cambiamento positivo per la sua vita,
ma, giudicata “indegna di vita”,
venne deportata nell’ospedale regionale di Pirna-Sonnenstein (in realtà
un centro di sterminio
dove furono uccise circa 15000 persone)
e assassinata nel quadro del programma di eutanasia nazista
“Aktion
T4”
il 31 luglio del 1940, gasata insieme ad altre venti donne, anche se la
causa ufficiale della morte fu quella di "polmonite con scompenso
cardiaco nonostante tutti gli sforzi fatti dai medici per mantenere il
paziente in vita”.
Nell’ultimo suo quadro,
Leben (Vita), del 1936, aveva raffigurato una donna come
crocefissa, con la testa pendente all'indietro, un poppante con ali
d'angelo che vomita.
Un giorno Elfriede aveva scritto:
Malgrado tutto quello attraverso cui sono passata sono abbastanza
stupida da credere che la gente buona esista ancora.
In vita nelle mostre i suoi quadri, fra “Espressionismo” e “Nuova
oggettività”, furono esposti accanto a quelli di Paul Klee, Oskar
Kokoschka ed Emile Nolde, dopo la morte, formalmente cancellata,
svanirono nell'oblio. A
lungo dimenticata, le sue opere superstiti, magnifiche, straordinarie se
si pensa in quale inferno furono create (in condizioni di semipovertà,
crisi nervose e isolamento emotivo), principalmente conservate in
collezioni private e musei in Germania, paesaggi, scene portuali, fiori,
animali, ritratti (di donne, uomini, vecchi, coppie, in solitudine, in
bar o in interni di squallidi ritrovi), due raffigurazioni della mitica
danzatrice Salomè, autoritratti (con cappello, con sigaretta), dipinti,
disegni, pastelli, oli, acquarelli, litografie, in cui sfila un’umanità
dolente, personaggi ai margini della società presentati nella loro
verità, nella crudezza delle loro condizioni, senza mai essere
moralmente giudicati, sono state riscoperte dai critici e divulgate a
partire dal
1989 con una serie di iniziative, eventi e mostre. Da allora sono state
esposte a
Aschaffenburg, insieme ai lavori di altre artiste tedesche, ad
Amburgo, a Dresda, a Pirna (nel museo della città, nel
2003, si è tenuta la mostra "Elfriede Lohse-Wächtler ... Io solo so chi
sono"), al Museo Zeppelin di Friedrichshafen (nel 2008, "Elfriede
Lohse-Wächtler - Una vita tra arte e disperazione"),
ed è stata anche istituita una fondazione che porta il suo nome,
Förderkreis Elfriede Lohse- Wächtler, riguadagnando, così, Elfriede,
riconoscimento e fama.
Inoltre, in ricordo di questa geniale artista e sensibile donna dal
destino sventurato e tragico, desiderosa di libertà e indipendenza,
definita eccentrica perché fumava e portava i capelli corti (ma a quel
tempo conquistare spazi per una donna passava anche attraverso
l’adozione di atteggiamenti e comportamenti “maschili”), catalogata come
“artista degenerata” solo perché creativa diversamente dai canoni
artistici allora imposti, etichettata come “schizofrenica” per un crollo
nervoso, in più con amici comunisti (considerati nemici acerrimi dallo
Stato come chiunque avversasse il nazismo),
nel 1999 è stata posta una lapide presso l'ospedale di Arnsdorf e nel
2004 è stato dato il suo nome ad un roseto nell’area dell’ex ospedale
Friedrich Ber. E vi sono anche delle strade a lei intitolate, a
Pirna-Sonnenstein, ad Arnsdorf, nell'area dell'ex dell'ospedale
Friedrichsberg, e nel 2012, nel giardino delle donne, nel cimitero
Ohlsdorfer di Amburgo, è stata apposta una lapide che la ricorda quale
vittima della persecuzione nazista.
NOTE
1)Dal nome dalla città di Weimar,
dove si tenne un'assemblea nazionale per redigere una nuova costituzione dopo
la sconfitta tedesca nella prima
guerra mondiale, la
Repubblica di Weimar (Weimarer
Republik, in tedesco) è il regime politico della storia
della Germania che va dal 1919 al 1933.
2) Come
scrive la giornalista e scrittrice Sarah Helm, nel libro dal titolo
evocativo dell’opera di Primo Levi, Ravensbrück: If this is a woman,
“Se questa è una donna”, a Ravensbrück, campo di sterminio ignorato
dalla storia per un lunghissimo periodo, vennero uccise, asfissiate,
seimila donne.