Piergiorgio
Cavallini
NAPOLI DI IERI
presentazione
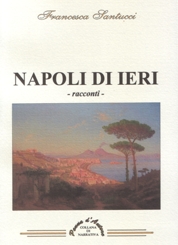
edizioni A.L.I.
Penna d'Autore, 2005
139 pagine- Prezzo: 10,00 euro
"Voglio bene, perché ci
son nato, al mondo dei vicoli e della povera gente del mio paese. Di tutti
i suoi mali sono depositario e amico, ne parlo perché li conosco, ne parlo
con la speranza di giustificarli, di dimostrare che prima di risolversi in
colpe i mali di Napoli sono soltanto dolore". Sono le parole che Giuseppe
Marotta pone ad epigrafe de L'oro di Napoli e che andrebbero
benissimo anche per questa raccolta di racconti di Francesca Santucci.
Coraggio da vendere, Francesca, a cimentarsi con un mostro sacro,
affascinante ma irto d'insidie, della napoletanità: mostro sacro perché da
sempre palestra di grandi scrittori, irto d'insidie perché, partendo da
basi (neo)realistiche, è grande il rischio di scivolare - attraverso il
folclore - nel bozzettistico, nei luoghi comuni del vulimmece bene
e d' 'o paese d'o sole. Ma irresponsabile io che oso presentare
questo lavoro, scendendo dalla comoda poltrona del lettore per salire
sullo scomodo scranno del critico ... ma qui, per dirla con Don Abbondio,
"il testimonio consolante della coscienza" mi viene in aiuto per
giustificare tanto ardire, nella fattispecie sotto la duplice forma
dell'amicizia e della stima che nutro per l'Autrice da un lato e,
dall'altro, di quel quarto di sangue napoletano - che per parte di nonno
materno - scorre nelle mie vene.
Anche Marotta aveva dedicato alla madre il suo libro, così come alla sua
l'ha dedicato Francesca, sulla scia dell'insanabile ferita della di lei
recente dipartita … e le madri sono uno degli elementi ricorrenti di
questa silloge, le madri protagoniste dei racconti della Santucci (le
parole madre e mamma ricorrono complessivamente 83 volte nel
testo), come pure le nonne, nominate 51 volte ... e, visto che
abbiamo cominciato, continuiamo a curiosare tra le concordanze di
Napoli di ieri, da me rudimentalmente prodotte col software
WordSmith di Michael Scott edito dalla Oxford University Press. Un
primo dato che salta all'occhio è la preponderanza dei femminili rispetto
ai maschili. Così, accanto alle 83 madri/mamme, abbiamo "solo" 63
fra padri e papà, accanto alle 51 nonne abbiamo 13
nonni (27 se consideriamo il plurale che comprende entrambi i nonni)
ed accanto ad uno stuolo di 136 donne troviamo una sparuta
pattuglia di 72 uomini (oltre a 13 femmine e 5 maschi).
Continuando, 37 bambine ed 11 bambini, 28 sorelle e
16 fratelli, 32 zie e 6 zii, 16 ragazze e 12
ragazzi; in parità i vecchi (20 a 20) e, sorprendentemente,
50 mariti contro 41 mogli. A questo punto spontanea deve
sorgere una domanda: Napoli pullula (o - per meglio dire - l'Arenaccia
pullulava) di donne o è la deformazione, per così dire, professionale
dell'Autrice a scrutare soprattutto le figure femminili e ad annetter
loro, consapevole od inconsapevolmente, un'importanza maggiore di quella
riconosciuta agli omologhi maschili? Io direi che è proprio la
deformazione professionale (sia detto, s'intende, in senso positivo)
dell'autrice e curatrice del sito www.letteraturaalfemminile.it a
suscitare questo interesse, ad acuire quest'angolatura, a riprova d'un
impegno che pervade di sé ogni atto letterario di Francesca e di cui in
detto sito si trova ampia testimonianza, alla quale rimando per il
completamento di questo discorso.
Ma tornando a Napoli - sempre basandoci sulle concordanze - possiamo
enucleare numerosi altri dati frequenziali che c'illuminano sulle scelte e
sulle preferenze narrative dell'Autrice. La parte preponderante del testo
- lessicalmente parlando - è feudo delle relazioni familiari ed
interpersonali, in un microcosmo che è quello delle case (nominate
più di 100 volte), intese come abitazioni e appartamenti, dove spiccano le
cucine (8), del quartiere (38), delle strade (15),
delle piazze (12), dei vicoli (8) e delle chiese (36)
(oltre ad 8 parroci ed 8 preti), del vicinato (16),
dei balconi (18) e delle bancarelle (4). In questo milieu
sociologico - piace notare - la parola lavoro ricorre solo 12
volte.
Un altro dato ch'emerge dalla lettura delle concordanze e che sgombera
definitivamente il terreno da quello che paventavo accingendomi a lèggere
questi racconti, cui dianzi accennavo quale potenziale rischio, è
l'assenza del bozzettistico, dei luoghi comuni della napoletanità, degli
stereotipi buoni per il turista americano. Infatti notiamo che il cielo
è nominato solo 8 volte, il sole 19 e il mare 20; la
pizza 25 - 8 volte la pizzeria - e il pane 10; la parola
canzone ricorre 11 volte, pasta 6, smorfia 6,
amore 5, pesce 5, presepe 5, cozze 4,
lungomare 4, mozzarella 4, pomodori 4, barca 3,
calzone 3, innamorati 3, nostalgia 3, quaterna
3, babà 2, femmenelli 2, napoletani 29.
Per quanto riguarda la parte onomasiologica - toponimi e antroponimi -
osserviamo che, per i primi, a parte Napoli nominata 57 volte,
Poggioreale viene citato 10 volte, l’Arenaccia 13 volte, mentre i
“mostri sacri” della toponomastica napoletana, in linea con la sobrietà
antimacchiettistica di sopra indicata, sono presenti in modo più che
discreto: Marechiaro 9 volte, Mergellina 7 e il Vesuvio
solo 3; per i secondi, mi limito ad osservare che quello che la fa da
padrone è Capecelàtro, che compare 21 volte e questa presenza,
avendo destato la mia curiosità di lettore, m’ha portato ad indagare più
da vicino la genesi e l’architettura del libro. Dietro i personaggi di
Vincenzo Capecelàtro e Giuseppina Arnone si celano Vincenzo Aprea e
Giuseppina Cariello, gli amatissimi nonni materni di Francesca, che in
realtà costituiscono il filo conduttore sottostante alla narrazione,
ricomparendo in diversi racconti, mentre l’occhio del narratore è quello
autobiografico di Francesca, che ha fuso armonicamente assieme ricordi,
sogni ed un bagaglio culturale antico che risale alla palliata e
che l’Autrice, opportunamente, indica in premessa.
Ma c’è un’altra figura – cui accennavo all’inizio - che domina questi
racconti, anche se da dietro le quinte, ed è quella della madre di
Francesca, recentemente scomparsa, vero cuore napoletano e tramite di
molti ricordi e di molte espressioni dialettali, tra le quali quella che
figura nel racconto Il medico di famiglia, che la Signora ripeteva
negli ultimi tempi, quasi presaga della sua fine imminente: “Lungo la
strada che la riportava a casa la povera signora Santoro, più sconsolata
che mai, pensava a se stessa e al poco tempo che le restava da vivere (e
amaramente si ripeteva: ‘Stongo c' 'o culo 'a fossa.’!)”.
Questo accenno alla parlata dialettale mi porta in un terreno a me amico,
in virtù della mia formazione accademica di filologo italiano e di
dialettologo. Non è certo questa la sede per aprire il discorso dei
dialetti e della loro inesorabile decadenza, né per dibattere del
contributo - positivo o negativo - degli scrittori (soprattutto dei poeti)
alla conservazione o alla disintegrazione della parlata dialettale. Quel
che mi preme segnalare è la nutrita presenza, mai affettata, in questi
racconti, di parole ed espressioni dialettali, talora anche in forma
dialogica come nel caso del bisticcio, spassosissimo, tra la vecchia Di
Gennaro e Giuseppina Arnone: Puozze sculà.- Cajotola.- Ciantella.-
Chiavettiera.- Sanguetta.- Capera.- Canimma.- Ruzzimma.- Mappina.- Femmena
senza zizze.- Zoccola ‘e saittera.- Di ogni espressione dialettale
viene data in nota la traduzione, quando occorre se ne propone
l’etimologia e si rimanda al Vocabolario napoletano-italiano, di
Camillo Andreoli. Soddisfacente anche l’indicazione delle principali fonti
letterarie, a sedare la bramosia di precisione delle mentalità
filologiche.
Insomma, una lettura assolutamente da non perdere, quella di Napoli di
ieri.
E la Napoli di oggi? L’intenzione originale era di non parlarne, ma giunto
alla fine di queste mie affabulazioni sento di doverlo fare, anche se di
sfuggita, se non altro per non far finta di non sapere quel che sta
accadendo oggi a Napoli, limitandomi però ad un solo accenno, assai
pertinente perché riferito allo stesso quartiere scenario di questo libro.
Curioso di sapere come stessero le cose, oggi, all’Arenaccia, ho lanciato
un ricerca in rete con una serie di parole chiave che consentissero di
capire – a me che vivo in tutt’altra realtà ed in una diversa area
geografica – quanto della Napoli di ieri di Francesca Santucci fosse
ancóra presente. Tra i tanti risultati ottenuti, tutti ahimé uniformi a
livello di compianto e commiserazione, ne cito uno, che ho trovato
all’indirizzo http://www.8colonne.it/PGNEWS10/PGNEW2.HTM, in cui
s’interviene - tra l’altro - sul degrado del monumento al più grande dei
tenori napoletani, che era originario del quartiere: “‘Stiamo organizzando
un comitato civico - spiega Giuseppe Giannini - per contrastare il degrado
dilagante e sollecitare le istituzioni a rimboccarsi le mani e recuperare
il quartiere. Via Arenaccia, via San Giovanni e Paolo e Piazza Ottocalli
sono dimenticate dal resto della città - riflette l'uomo - i problemi sono
tanti: la sicurezza, la viabilità, la riqualificazione degli spazi
pubblici’. Sulla stessa lunghezza d'onda Raffaele Tubelli, del neo
comitato civico: ‘Stiamo raccogliendo le energie sane della zona - sbotta
- per cercare d'invertire la tendenza che vuole questo pezzo di Napoli,
terra di nessuno. Enrico Caruso per gli abitanti dell'Arenaccia - conclude
Tubelli - è un vanto, non è giusto che la sua memoria sia così
barbaramente offesa e oltraggiata’”.
Chissà che questo libro di Francesca Santucci non porti un contributo al
risveglio delle “energie sane” dell’Arenaccia.
Piergiorgio Cavallini
La Spezia, 4 dicembre 2004


![]()
